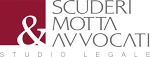
Annullabilità delle dimissioni rassegnate dal dipendente minacciato di licenziamento
La Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro, con la recente ordinanza numero 7190 del 18 marzo 2024, si è pronunciata sull’annullabilità delle dimissioni rassegnate dal lavoratore minacciato di licenziamento.
La vicenda
La fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione trova origine nella domanda proposta da un ex dipendente per l’ammissione al passivo del fallimento dell’impresa per cui lavorava, in privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, del Codice Civile, per ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate da agosto 2009 alla successiva data di dichiarazione del fallimento (avvenuta nel dicembre del 2017), nonché per un ulteriore importo in prededuzione per il periodo successivo, previo accertamento della nullità dell’atto di “apparenti dimissioni” posto in essere nel 2009 per violazione di norme imperative; ovvero, in via subordinata, con l’annullamento dell’anzidetto atto di dimissioni (siccome affetto di violenza o dolo ai sensi dell’art. 428 c.c.) e conseguenti accertamento e declaratoria che il rapporto di lavoro subordinato era proseguito senza soluzione di continuità (con diritto alle retribuzioni maturate in tutto il periodo intercorrente dalle apparenti dimissioni al fallimento).
Il lavoratore, a sostegno della propria domanda, esponeva in particolare di essere stato costretto a presentare una lettera di dimissioni compilata sotto dettatura di due responsabili dell’azienda, che lo minacciavano altrimenti di conseguenze pregiudizievoli. Inoltre, esponeva di avere denunciato i fatti, con conseguente apertura di un procedimento penale per il delitto di estorsione “in concorso” nel quale si era costituito parte civile; procedimento in relazione al quale il Tribunale competente aveva dichiarato estinto il reato nei confronti di un imputato per morte del reo, mentre aveva condannato l’altro imputato, previa riqualificazione del fatto, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, e aveva per l’effetto dichiarato la società responsabile civile, con condanna solidale al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato alla parte civile. Successivamente, in sede di appello, il fatto veniva riqualificato nel reato di violenza privata, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, restando ferme le statuizioni civili. Infine, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione dichiarava inammissibili i ricorsi dell’imputato e della parte civile.
A fronte di ciò, il Giudice Delegato rilevava, fra l’altro, che: a) non ricorrevano i presupposti per la declaratoria di nullità del licenziamento, dovendosi semmai porre il problema dell’annullabilità della dichiarazione di dimissioni per violenza, rispetto alla quale era però decorso il termine quinquennale di prescrizione; b) in ogni caso, le conseguenze pregiudizievoli scaturenti dalla violenza privata subita dovevano essere quantificate in relazione al pregiudizio effettivo, tenendo conto che dopo le dimissioni il ricorrente aveva ripreso a lavorare presso altra società con contratti a tempo determinato, salvo un periodo di sospensione; c) il danno subìto doveva essere quantificato nella perdita della retribuzione per il periodo di 9 mesi non lavorati e d) l’istante andava ammesso al passivo quale creditore in privilegio e quale creditore chirografario a titolo di spese liquidate nelle sentenze di primo e secondo grado.
Il lavoratore proponeva opposizione allo stato passivo, insistendo nelle proprie pretese fondate sul prospettato diritto al percepimento delle retribuzioni con conseguente ricostituzione della posizione giuridica e con valutazione del credito come se il rapporto fosse proseguito senza soluzione di continuità, piuttosto che come risarcimento del danno.
Successivamente, il Tribunale adito rigettava l’opposizione, specificando che in sede penale era stata accertata la sussistenza di condotta criminosa di cui all’art. 610 del Codice Penale, con declaratoria che di tale fatto dovesse rispondere la società poi fallita ai sensi degli artt. 2049 del Codice Civile e 185 del Codice Penale. Da tale accertamento non discendeva la nullità dell’atto di dimissioni o un licenziamento, trattandosi di “reato in contratto”, in cui si punisce il comportamento tenuto da una delle parti nella fase di formazione o di esecuzione; di talché, non rileva il contratto in sé, ma rilevano le modalità (frode, violenza, minacce) mediante le quali lo stesso viene concluso o eseguito. Ciò, con l’ulteriore conseguenza che, nel caso in esame, si trattava non di atto di licenziamento nullo, bensì di dimissioni annullabili, a fronte delle quali il lavoratore non aveva esercitato tempestivamente l’azione nel termine di prescrizione di 5 anni (mancando anche atti interruttivi validi). In ragione di ciò, l’unico criterio risarcitorio utilizzabile rimaneva quello equitativo, comprendente il periodo di effettiva non occupazione, somma da considerarsi satisfattiva unita a quella assegnata in provvisionale in sede penale.
Il lavoratore, a tutela dei propri diritti, riteneva quindi di proporre ricorso per cassazione.
Ciò, contestando sia la ricostruzione giuridica della fattispecie, operata dal Tribunale, in termini di “reato in contratto” oltreché negando di aver mai richiesto in sede civile il risarcimento del danno (avendo invece e piuttosto domandato il pagamento delle retribuzioni dalla data delle dimissioni contestate alla data del fallimento); sia le ulteriori statuizioni rese in punto di prescrizione dell’azione di annullamento (della relativa eccezione e della validità degli atti interruttivi allegati in atti).
La ricostruzione interpretativa della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nella decisione in rassegna, ha ritenuto pregiudiziale lo scrutinio delle censure concernenti la correttezza della riconduzione della fattispecie concreta a quella astratta del “reato in contratto” e la tematica del diritto alle retribuzioni (anziché al risarcimento del danno) per effetto della prospettata possibilità di qualificare le dimissioni contestate in termini di nullità, ritenendole infine infondate, con l’assorbimento degli altri motivi di ricorso (e il suo rigetto).
In particolare la Corte, facendo riferimento ad altre precedenti decisioni della stessa, ha stabilito che non è possibile individuare un automatismo tra nullità e atto di autonomia privata posto in essere in violazione di una norma penale. Infatti, la giurisprudenza ha affermato che “… nella prospettiva del diritto civile, non è sufficiente, per aversi nullità del negozio, che sia sanzionata, anche penalmente, la condotta di colui o coloro che l’hanno posto in essere, dovendo farsi oggetto di verifica, piuttosto, le finalità perseguite e gli interessi tutelati dalla norma violata; l’individuazione del trattamento civilistico dell’atto negoziale che si confronti con una fattispecie di reato dipende dal rapporto che, di volta in volta, si abbia tra reato e contratto o negozio” (ex multis: Cass. n. 17959/2020, n. 26097/2016).
Ad avviso del Collegio, tradizionalmente, quando il negozio si è concluso commettendo un reato, si usa distinguere l’ipotesi dei reati commessi nell’attività di conclusione di un contratto, cioè dei cd. “reati in contratto”, e l’ipotesi dei reati che consistono nel concludere un determinato contratto, in sé vietato, cioè dei cd. “reati contratto”, tracciando la seguente distinzione: nel caso in cui la norma incriminatrice penale vieti proprio la stipulazione del contratto, in ragione dell’assetto degli interessi che esso mira a realizzare, si è al cospetto del cd. “reato-contratto”; viceversa, allorquando la norma penale sanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell’altro nella fase della stipulazione, rileva la categoria concettuale del cd. “reato in contratto”.
La Corte ha quindi affermato che “… in altri termini, in tema di cause di nullità del negozio giuridico, per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell’art. 1418 c. c., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazione integri reato, mentre non rileva il divieto che colpisca soltanto un comportamento materiale delle parti o di una sola di esse (Cass. n. 18016/2018)” per cui, secondo tale chiave interpretativa, è stato affermato che il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione è affetto da nullità ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile (cfr., Cass. n. 17568/2022, n. 17959/2020).
Diversamente, la pacifica giurisprudenza ha affermato che “le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale, qualora venga accertata l’inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell’inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso” (ex multis: Cass. n. 41271/2021, n. 8298/2012, n. 24405/2008; Cass. n. 18930/2016).
Inoltre, è stato anche chiarito che la violenza morale esercitabile dal datore di lavoro, che può determinare l’annullabilità delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, può esprimersi secondo modalità variabili e indefinite, anche non esplicite (Cass. n. 24363/2010) e che “le dimissioni rassegnate dal lavoratore sono annullabili per violenza morale ove siano determinate da una condotta intimidatoria, oggettivamente ingiusta, tale da costituire una decisiva coazione psicologica, risolvendosi il relativo accertamento da parte del giudice di merito in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio” (Cass. n. 16161/2015).
La decisione
Assumendo la configurabilità delle dimissioni in esame quale conseguenza del reato di violenza privata, così come qualificato in sede penale il comportamento del rappresentante del datore di lavoro (e da cui discende la responsabilità civile di parte datoriale), la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in rassegna, nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha infine ritenuto condivisibili le statuizioni del Tribunale, nei termini di:
– ricorrenza, nel caso concreto, di “reato in contratto”, determinante vizio del consenso per effetto di violenza morale su una delle parti del negozio;
– conseguente annullabilità (e non nullità) dell’atto di dimissioni;
– insussistenza del diritto al pagamento delle retribuzioni maturate da agosto 2009 a dicembre 2017, oggetto della domanda di ammissione al passivo come azionata dal ricorrente.
Nel caso di specie, quindi, secondo la Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro, si è concretizzata un’ipotesi di “reato in contratto”, determinato dal vizio del consenso per effetto di violenza privata su una delle parti del negozio, con conseguente annullabilità dell’atto di dimissioni.
In ragione di ciò, il lavoratore ha diritto alla qualificazione e quantificazione del risarcimento sulla base del criterio equitativo, comprendente il periodo di effettiva non occupazione e non, come egli avrebbe voluto, il ripristino dello status quo ante con diritto a percepire tutte le retribuzioni maturate dal giorno in cui ha presentato le proprie dimissioni sino a quello della pronuncia definitiva.

