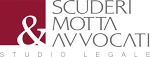
Sulla (il)legittimità costituzionale dell'indistinto obbligo per il concessionario (senza gara) di esternalizzare una quota dei contratti
La Corte Costituzionale – a seguito di ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato (rectius sentenza non definitiva), iscritta al numero 166 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2020 – con la recente decisione del 23 novembre 2021, n. 218, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera iii), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e dell’art. 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per violazione degli artt. 3, secondo (recte: primo) comma, 41, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione.
In particolare, le disposizioni censurate prevedono – in capo ai titolari delle concessioni già in essere, non assegnate con la formula della finanza di progetto o con procedure a evidenza pubblica – l’obbligo di: a) esternalizzare, mediante affidamenti a terzi con procedura di evidenza pubblica, l’80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro; b) nonché di realizzare, la restante parte di tali attività, tramite società in house o società controllate o collegate ovvero operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
Di poi, il comma secondo dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici fissa il termine entro il quale le concessioni devono adeguarsi alle predette disposizioni; il comma terzo, invece, disciplina la verifica – da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC – del rispetto dei limiti prescritti al suddetto comma primo “…secondo le modalità indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
La ratio di tale normativa (come esplicitata nel parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 20 giugno 22018, n. 1582) è quella di “… restituire, a valle, parte della concorrenza“per il mercato” che è mancata a monte, secondo uno schema che …ha ad oggetto, in quota parte, le prestazioni relative alle concessioni a suo tempo affidate direttamente…” (e dunque con modalità, “non concorrenziali”).
Sulla legittimità di tale normativa ha dubitato, tuttavia, il Consiglio di Stato, il quale – in veste di giudice d’appello – verificato che la questione a lui sottoposta fosse rilevante e non manifestamente infondata, ha investito la Corte costituzionale.
Per una migliore comprensione della vicenda occorre, tuttavia, fare breve menzione anche del giudizio di prime cure.
Il giudizio di primo cure
Una società – concessionaria del servizio di illuminazione pubblica – ha proposto, innanzi al TAR Lazio, ricorso, al fine di ottenere l’annullamento della delibera dell’ANAC 4 luglio 2018, n. 614 , con cui sono approvate le Linee guida n. 11 (recanti: «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea»), adottate in applicazione dell’art. 117, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
In particolare, la società – dopo avere impugnato, con motivi aggiunti, anche l’Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento dell’ANAC 17 ottobre 2018, n. 4 – ha dedotto l’illegittimità delle suddette linee guida e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale delle medesime e dell’art. 177 del Codice dei contratti pubblici in riferimento agli artt. 3, 11, 41, 76, 97 e 117 Cost.
Il TAR Lazio, tuttavia, in accoglimento della eccezione preliminare sollevata dalla difesa erariale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, per carenza di immediata e concreta lesività delle linee guida “…in quanto la lesione della posizione giuridica dei concessionari sarebbe derivata non già dalle prescrizioni in essi contenute, ma dall’eventuale successivo atto applicativo di contestazione dell’esistenza di una «situazione di squilibrio», all’esito della prima verifica annuale successiva alla scadenza del termine per l’adeguamento alle previsioni dell’art. 177, comma 3, cod. contratti pubblici”.
Il giudizio di appello
Avverso la suddetta sentenza, la società ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, contestando, anzitutto, la pronuncia gravata là dove il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di lesività delle linee guida; la società appellante ha dedotto, altresì, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, l’illegittimità delle linee guida n. 11 e l’illegittimità costituzionale delle medesime linee guida e dell’indicato art. 177 del Codice dei contratti pubblici.
Ebbene, il Massimo organo di giustizia amministrativa – dopo aver ritenuto fondato il primo motivo di appello (atteso che le linee guida “… sebbene formalmente articolate in due parti, esse [costituiscono], «dal punto di vista logico e sistematico un corpus regolatorio unico, in cui la parte I (di natura dichiaratamente interpretativa) è finalizzata ad individuare il corretto ambito di applicazione dell’art. 177, su cui sono destinate ad incidere le indicazioni contenute nella seconda parte». In questo contesto l’unicità dell’atto regolatorio impugnato farebbe sì che «la distinzione fra la natura interpretativa e non vincolante della parte I e quella prescrittiva e vincolante della parte II receda nell’apprezzamento della portata immediata e direttamente lesiva – e quindi impugnabile in sede giurisdizionale amministrativa – delle Linee Guida nel loro complesso») – ha proseguito, dunque, con l’esame delle censure relative alla legittimità costituzionale della previsione di cui all’art. 177, comma 3, del Codice dei contratti e della norma di delega (art. 1, comma 1, lettera iii, della legge n. 11 del 2016).
Infatti, preliminarmente, il Consiglio di Stato ha escluso la possibilità di una interpretazione costituzionalmente conforme delle disposizioni censurate, fornita dalla società appellante – la quale ha sostenuto che “….per escludere l’effetto di una intera dismissione della concessione affidatale, si dovrebbe computare la «quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni» sulla sola parte della concessione che il suo titolare intenda effettivamente esternalizzare” – atteso che ciò significherebbe “…rimettere alla sola volontà del concessionario la scelta sull’esternalizzazione”.
Il Consiglio di Stato, dunque, passando al merito delle censure, ha ritenuto che le questioni di legittimità prospettate dalla società appellante fossero:
- rilevanti ai fini del giudizio sottoposto al suo esame, “…giacché le linee guida in esso impugnate – quanto alle indicazioni contenute nella loro Parte I – costituiscono coerente interpretazione e diretta applicazione dell’art. 177, comma 1, cod. contratti pubblici, a sua volta emanato in attuazione del criterio direttivo enunciato nel citato art. 1, comma 1, lettera iii), della legge delega n. 11 del 2016, mentre – quanto alle indicazioni contenute nella loro Parte II – si presentano come il «presupposto per l’esercizio dei poteri di controllo e sanzionatori dell’Autorità di vigilanza di settore»;
- non manifestamente infondate, sia sotto il profilo della libertà di impresa, sancita dall’art. 41 Cost che sotto il profilo della ragionevolezza (con riguardo all’art. 3, primo comma, Cost.). Sarebbe ancora violato l’art. 97, secondo comma, Cost. per il fatto che né la norma delegante né quella delegata considerano gli effetti della imposta dismissione sull’efficiente svolgimento di servizi pubblici essenziali.
Con sentenza non definitiva del 19 agosto 2020, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2020, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha sollevato, quindi, questioni di legittimità costituzionale delle norme di cui si discute.
Il giudizio della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, prima di esaminare il merito delle questioni sottoposte al suo esame, ha fornito una sintetica ricostruzione della genesi e della evoluzione della normativa censurata, tenendo conto sia della disciplina comunitaria che di quella nazionale di recepimento.
In particolare, la Corte ha evidenziato come, da un lato, la normativa comunitaria, con le varie direttive che si sono succedute nel tempo, ha previsto una mera facoltà per l’amministrazione aggiudicatrice di imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una certa soglia minima; dall’altro, a livello nazionale, invece, l’art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ha stabilito un obbligo ad appaltare a terzi i lavori pubblici (articolo poi modificato e, successivamente, abrogato dall’art. 256 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
Orbene, in tale ricostruzione normativa si colloca il censurato principio e criterio direttivo della legge di delega n. 11 del 2016, il quale prevede “l’obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all’80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica». Si stabilisce, inoltre, «che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato”.
La sostanza normativa del suddetto principio e criterio direttivo è stata, pressoché, integralmente riprodotta nell’art. 177, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Ciò posto, la Corte Costituzionale ha esaminato e ritenuto fondate le censure prospettate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 41, primo comma, Cost., osservando preliminarmente ed in termini generali come se è pur vero che la libertà di iniziativa economica – garantita dall’art 41 della Carta Costituzionale – possa essere, certamente, limitata in nome della tutela della concorrenza, tuttavia, tale compressione deve essere frutto di un bilanciamento, che deve tenere in considerazione anche le legittime aspettative degli operatori economici.
Di talchè “se, .., legittimamente in base a quanto previsto all’art. 41 Cost., il legislatore può intervenire a limitare e conformare la libertà d’impresa in funzione di tutela della concorrenza, nello specifico ponendo rimedio ex post al vulnus conseguente a passati affidamenti diretti avvenuti al di fuori delle regole del mercato, il perseguimento di tale finalità incontra pur sempre il limite della ragionevolezza e della necessaria considerazione di tutti gli interessi coinvolti. La libertà d’impresa non può subire infatti, nemmeno in ragione del doveroso obiettivo di piena realizzazione dei principi della concorrenza, interventi che ne determinino un radicale svuotamento, come avverrebbe nel caso di un completo sacrificio della facoltà dell’imprenditore di compiere le scelte organizzative che costituiscono tipico oggetto della stessa attività d’impresa“.
Muovendo da tale premessa, la Corte ha ritenuto che la previsione dell’obbligo a carico dei titolari di concessioni già in essere, di cui all’art 177 del Codice dei contratti e della legge di delega, “…costituisca una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine perseguito, in quanto tale lesiva della libertà di iniziativa economica…”, con conseguente sua illegittimità costituzionale.
Tale irragionevolezza discende, secondo la Corte Costituzionale, anzitutto ed in particolare dal fatto che: “…la parte più grande delle attività concesse deve essere appaltata a terzi e la modesta percentuale restante non può comunque essere compiuta direttamente. L’impossibilità per l’imprenditore concessionario di conservare finanche un minimo di residua attività operativa trasforma la natura stessa della sua attività imprenditoriale, e lo tramuta da soggetto (più o meno direttamente) operativo in soggetto preposto ad attività esclusivamente burocratica di affidamento di commesse, cioè, nella sostanza, in una stazione appaltante”. Né potrebbe essere rilevante osservare che “…resterebbero comunque garantiti i profitti della concessione, giacché, anche a prescindere da ogni considerazione di merito al riguardo, è evidente che la garanzia della libertà di impresa non investe soltanto la prospettiva del profitto ma attiene anche, e ancor prima, alla libertà di scegliere le attività da intraprendere e le modalità del loro svolgimento”.
Continua ancora, evidenziando che “…un ulteriore indice della irragionevolezza del vincolo, così come definito dalla previsione censurata, è costituito dalla sua mancata differenziazione o graduazione in ragione di elementi rilevanti, nel ricordato bilanciamento, per l’apprezzamento dello stesso interesse della concorrenza, quali fra gli altri le dimensioni della concessione – apparendo a tale fine di scarso rilievo la prevista soglia di applicazione alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro, normalmente superata dalla quasi totalità delle concessioni –, le dimensioni e i caratteri del soggetto concessionario, l’epoca di assegnazione della concessione, la sua durata, il suo oggetto e il suo valore economico….”.
Peraltro, secondo la Corte Costituzionale, “… il legislatore ha poi omesso del tutto di considerare l’interesse dei concessionari che, per quanto possano godere tuttora di una posizione di favore derivante dalla concessione ottenuta in passato, esercitano nondimeno un’attività di impresa per la quale hanno sostenuto investimenti e fatto programmi, riponendo un relativo affidamento nella stabilità del rapporto instaurato con il concedente.”.
Di poi, “…l’introduzione di un obbligo radicale e generalizzato di esternalizzazione, come quello disposto nella normativa censurata, non supera nemmeno – nello scrutinio del bilanciamento operato fra diritti di pari rilievo – la doverosa verifica di proporzionalità”, atteso che “…non si può certo dire che con essa il legislatore abbia dato la preferenza al “mezzo più mite” fra quelli idonei a raggiungere lo scopo, scegliendo, fra i vari strumenti a disposizione, quello che determina il sacrificio minore…”.
Il legislatore, cioè, il quale è tenuto a perseguire l’obiettivo di tutela della concorrenza, non avrebbe dovuto farlo attraverso la previsione di “…una misura radicale e ad applicazione indistinta…”, ma in maniera tale da “…calibrare l’obbligo di affidamento all’esterno sulle varie e alquanto differenziate situazioni concrete…”
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni su dette, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 177, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, da cui deriva l’illegittimità costituzionale anche dei successivi commi 2 e 3.
Sono rimaste assorbite, invece, le censure prospettate dal Consiglio di Stato rimettente in riferimento all’art. 97, secondo comma, Cost.

