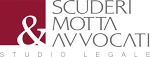
Gli affidamenti "in house" al vaglio della Corte Costituzionale
Non è costituzionalmente illegittimo, per vizio di delega, l’art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016, laddove prevede un onere motivazionale supplementare circa le ragioni del mancato ricorso al mercato, per il caso in cui la Pubblica Amministrazione si determini per l’affidamento diretto in favore di una società c.d. in house.
Così si è espressa da ultimo la Corte Costituzionale che, con la sentenza n.100 del 27 maggio 2020, ha alla fine ritenuto non fondate, pur se “plausibilmente” rilevanti, le questioni di incostituzionalità sollevate dal TAR Liguria (con ordinanza del 15 novembre 2018 n.886) il quale aveva per l’appunto dubitato della costituzionalità della citata disposizione di legge, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti diano conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, ritenendo che la previsione d’un tale onere motivazionale supplementare avesse ecceduto rispetto ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 11 del 2016, in violazione dell’art. 76 della Costituzione.
E ciò, secondo la prospettazione del Giudce remittente, avuto particolare riguardo – d’un canto – al c.d. divieto di gold plating di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) della legge delega n.11/2016, e dall’altro ai principi e criteri di cui alla successiva lettera eee), relativi alla garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico (per l’appunto, i cosiddetti affidamenti in house).
La Suprema Corte, con la decisione in rassegna – osservando come l’ordinanza di rimessione riproponesse “sotto l’angolo visuale del vizio di delega, il noto dibattito, particolarmente vivo nella giurisprudenza amministrativa, sulla natura generale o eccezionale dell’affidamento in house” – ha ritenuto che le questioni di costituzionalità portate alla sua attenzione non fossero fondate “in relazione ad entrambi i parametri interposti dedotti“.
In particolare, quanto al primo profilo relativo al divieto del c.d. gold plating, la Corte ha ritenuto di precisare in primo luogo che “..il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive comunitarie (il cosiddetto gold plating) è imposto da tale criterio direttivo e dalle norme da esso richiamate, ma non è un principio di diritto comunitario, il quale, come è noto, vincola gli Stati membri all’attuazione delle direttive, lasciandoli liberi di scegliere la forma e i mezzi ritenuti più opportuni per raggiungere i risultati prefissati (salvo che per le norme direttamente applicabili)…”.
Quindi, ha rammentato come un tale divieto – peraltro menzionato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, dell’8 ottobre 2010, ove quanto al «fenomeno delle “regole aggiuntive”», per l’appunto il cosiddetto “gold plating”, si precisa peraltro che tale termine «…si riferisce alla prassi delle autorità nazionali di regolamentare oltre i requisiti imposti dalla legislazione UE, in sede di recepimento o di attuazione in uno Stato membro..» – è stato introdotto, nel nostro ordinamento dall’art. 15, comma 2, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 [recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)»] con l’inserimento nell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), dei commi 24-bis, ter e quater.
Rammentando ancora come, per il comma 24-bis, gli «.. atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater»; laddove il comma 24-ter, « …poi, puntualizza quali debbano intendersi livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie, ovvero: «a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive; b) l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; c) l’introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle direttive»; ed infine, il comma 24-quater, dispone che l’amministrazione «.. dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell’analisi d’impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le
Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».
«Ebbene» , prosegue la Corte, le disposizioni appena menzionate illustrano chiaramente che «..la ratio del divieto, assurto a criterio direttivo
nella legge delega n. 11 del 2016, è quella di impedire l’introduzione, in via legislativa, di oneri amministrativi e tecnici, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria, che riducano la concorrenza in danno delle imprese e dei cittadini, mentre è evidente che la norma censurata si rivolge all’amministrazione e segue una direttrice proconcorrenziale, in quanto è volta ad allargare il ricorso al mercato… » (come peraltro riconosciuto anche dall’Adunanza della commissione speciale del Consiglio di Stato, nel parere n. 855 del 1° aprile 2016, relativo allo schema di decreto legislativo recante «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 gennaio 2016, n. 11», nonchè dalla stessa giurisprudenza comunitaria: cfr. Corte di giustizia, nona sezione, ordinanza 6 febbraio 2020, in cause da C-89/19 a C-91/19, Rieco spa, resa su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, sezione quinta, con ordinanze 7
gennaio 2019, n. 138 e 14 gennaio 2019, n. 293 e n. 296; nello stesso senso, Corte di giustizia, quarta sezione, sentenza 3 ottobre 2019, in causa C-285/18, Irgita).
Di talchè, conclude la Suprema Corte sul punto, «.. l’obbligo di motivazione sulle ragioni del mancato ricorso al mercato imposto dall’art. 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che risponde agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza, non è … in contrasto con il criterio previsto dall’art. 1 comma 1, lettera a), della legge delega n. 11 del 2016..» .
Quanto poi al secondo profilo di incostituzionalità ipotizzato in sede di rimessione, la Suprema Corte ha ritenuto come, anche in tal caso, non sussista alcuna violazione dell’art. 1, comma 1, lettera eee), della medesima legge delega, osservando anzitutto che il criterio direttivo ivi delineato «..trova il suo epicentro non tanto nel generico obbligo di adeguata pubblicità e trasparenza – che, in quanto principio fondamentale dell’azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), non richiede una conferma nelle normative di settore – quanto nel suo essere riferito, in particolare, agli affidamenti diretti, segno di una specifica attenzione a questo istituto già da parte del legislatore delegante ..». E ritenendo, inoltre, che la valutazione sulla scelta del legislatore delegato di imporre, per tali casi, un onere di motivazione (rafforzata) circa il mancato ricorso al mercato debba essere effettuata « ..anche alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, che riconosce al legislatore delegato margini di discrezionalità e la necessità di tener conto del quadro normativo di riferimento (sentenze n. 10 del 2018, n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, e n. 119 del 2013), specie quando la delega “riguardi interi settori di disciplina o comunque organici complessi normativi” (sentenza n. 10 del 2018; nello stesso senso, sentenze n. 229 del 2014 e n. 162 del 2012)… » ; criterio interpretativo, quest’ultimo, che la Corte ha ritenuto « ..particolarmente calzante nel caso in esame, in cui si è in presenza di un “codice”, che, come è tipico di tale corpo normativo nell’ambito amministrativo, nell’adeguare la normativa nazionale alle direttive europee, si prefigge anche lo scopo di razionalizzare una disciplina di settore stratificatasi nel tempo…» .
Sulla scorta di tali coordinate, dunque, la Corte ha rilevato che « ..la norma delegata, in effetti, è espressione di una linea restrittiva del ricorso all’affidamento diretto che è costante nel nostro ordinamento da oltre dieci anni, e che costituisce la risposta all’abuso di tale istituto da parte delle amministrazioni nazionali e locali… » (cfr. Relazione AIR dell’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC, relativa alle “Linee guida per l’istituzione dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell’art. 192 del codice dei contratti pubblici“; art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e poi abrogato a seguito di referendum; art. 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221; art. 7, comma 3, dello schema di decreto legislativo di riforma dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, adottato ai sensi degli artt. 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).
«Si tratta», continua la Corte, « .. di una scelta di fondo già vagliata da questa Corte, che – con specifico riferimento alle condizioni allora poste dall’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, ma con affermazioni estensibili anche al caso odierno – ha osservato: “[s]iffatte ulteriori condizioni […] si risolvono in una restrizione delle ipotesi in cui è consentito il ricorso alla gestione in house del servizio e, quindi, della possibilità di derogare alla regola comunitaria concorrenziale dell’affidamento del servizio stesso mediante gara pubblica. Ciò comporta, evidentemente, un’applicazione più estesa di detta regola comunitaria, quale conseguenza di una precisa scelta del legislatore italiano. Tale scelta, proprio perché reca una disciplina pro concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario, non è da questo imposta – e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi del primo comma dell’art. 117 Cost., come sostenuto dallo Stato –, ma neppure si pone in contrasto […] con la citata normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire l’assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri. È infatti innegabile l’esistenza di un “margine di apprezzamento” del legislatore nazionale rispetto a princìpi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti dall’ordinamento comunitario con riguardo ad un valore ritenuto meritevole di specifica protezione, quale la tutela della concorrenza “nel” mercato e “per” il mercato» (sentenza n. 325 del 2010; nello stesso senso, sentenza n. 46 del 2013)… ».
Concludendosi pertanto nel senso che « …la specificazione introdotta dal legislatore delegato è riconducibile all’esercizio dei normali margini di discrezionalità ad esso spettanti nell’attuazione del criterio di delega, ne rispetta la ratio ed è coerente con il quadro normativo di riferimento (tra le tante, sentenze n. 10 del 2018, n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, e n. 119 del 2013)..», con conseguente infondatezza anche dell’ulteriore questione di costituzionalità sollevata dal remittente in riferimento all’art. 76 Cost. ed in relazione all’art. 1, comma 1, lettere a) ed eee), della legge n. 11 del 2016.

